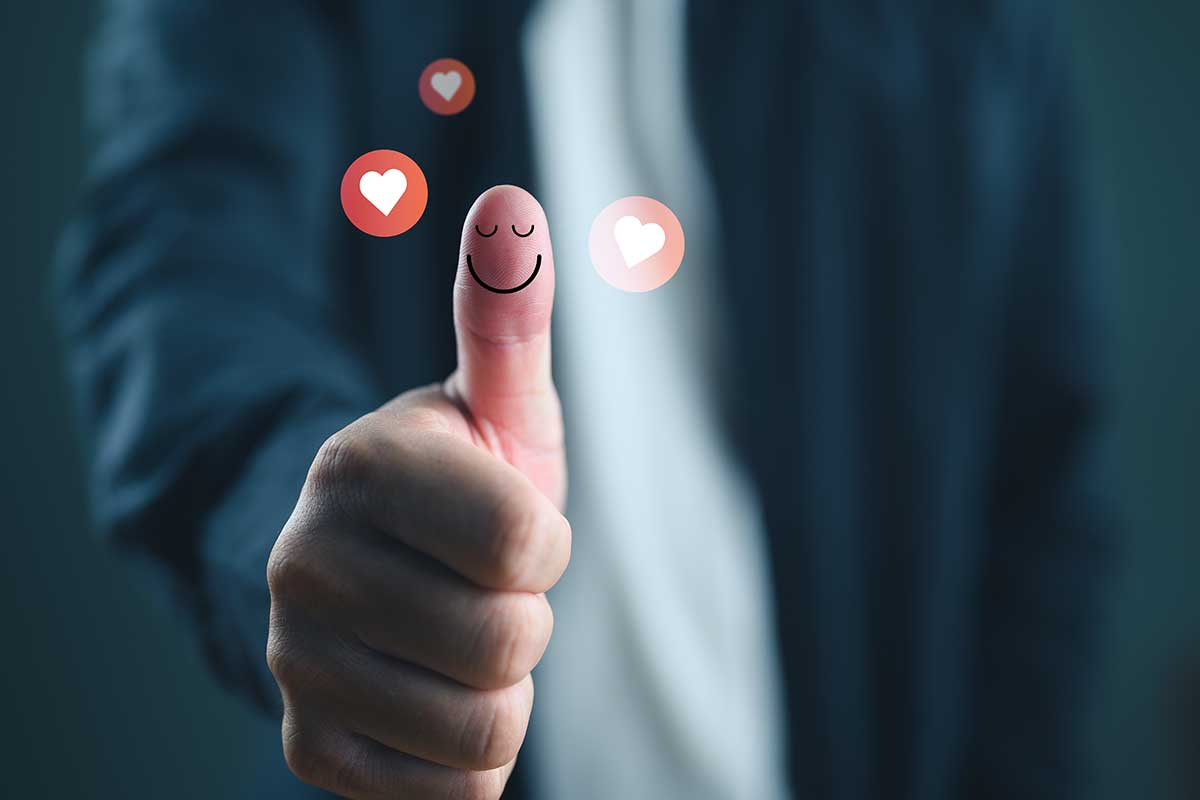La Giornata Nazionale della Dislessia è un appuntamento importante per parlare dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) più diffusi. In Italia ricorre il 8 ottobre, ma rientra all’interno di una settimana di sensibilizzazione.
Perché parlare di dislessia
La Giornata ha l'obiettivo di trasformare la percezione di questo disturbo, spingendo verso una maggiore inclusione a scuola e nella società. Riconoscere la dislessia significa garantire a milioni di persone, soprattutto bambini e ragazzi, gli strumenti necessari per esprimere appieno il loro potenziale. La dislessia non è un problema di cosa si apprende, ma di come lo si apprende.
Che cos'è la dislessia e quali sono i segnali
La dislessia è un Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) di origine neurobiologica. Significa che la difficoltà non deriva da un quoziente intellettivo basso o da problemi sensoriali (vista, udito), ma da una diversa organizzazione cerebrale che rende difficoltosa l'automatizzazione dei processi di lettura e decodifica.
I segnali chiave di allarme, che dovrebbero spingere all'osservazione specialistica, includono:
- Difficoltà nella lettura fluente: la lettura è lenta, stentata e faticosa, spesso con perdite di riga.
- Errori di decodifica: scambio o inversione di lettere simili (b al posto di d, p al posto di q), o inversione di sillabe all'interno delle parole.
- Difficoltà nell'automatizzazione: problemi nella memorizzazione di sequenze (come le tabelline, i giorni della settimana o l'alfabeto).
- Problemi di ortografia evidenti e persistenti.
I dati in Italia
I dati del Ministero dell'Istruzione mostrano che i DSA, di cui la dislessia è la forma più frequente, interessano una percentuale significativa degli studenti italiani, stimata attorno al 4-5% della popolazione scolastica. Questa prevalenza rende la dislessia un fenomeno sociale di grande rilevanza, che richiede un'attenzione costante da parte delle istituzioni educative.
Come si riconosce
Il riconoscimento ufficiale della dislessia non può avvenire prima della fine della seconda classe della scuola primaria per la lettura e la scrittura, e della terza classe per il calcolo. L'iter diagnostico è multidisciplinare e coinvolge:
- Neuropsichiatra Infantile: valuta le condizioni neurobiologiche generali e l'assenza di altre patologie.
- Psicologo: valuta il livello cognitivo (QI) per escludere un ritardo intellettivo (la diagnosi di DSA richiede un QI nella norma).
- Logopedista: esegue i test specifici sulla lettura, scrittura e calcolo per misurare la distanza dalle prestazioni attese per l'età e la classe frequentata.
La diagnosi porta all'attivazione delle tutele previste dalla Legge 170/2010.
Come si gestisce la dislessia
È fondamentale chiarire che la dislessia non è una malattia e non ha una "cura" nel senso tradizionale del termine. È una caratteristica neurobiologica permanente che si gestisce attraverso l'intervento e l'adattamento.
- Intervento abilitativo: sessioni mirate con specialisti (soprattutto logopedisti) per migliorare e rendere più efficienti le abilità di base.
- Strumenti compensativi: sono strumenti tecnologici che aggirano l'ostacolo. I principali sono la sintesi vocale (che legge il testo al posto dello studente), il registratore (per non dovere prendere appunti scritti) e le mappe concettuali
- Misure dispensative: sono esenzioni da compiti che aggravano la difficoltà, come la lettura ad alta voce in classe, l'eccessivo carico di copiatura dalla lavagna o la maggior parte del tempo per le verifiche.
Tutto il piano di supporto a scuola viene formalizzato nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), obbligatorio per legge.
I DSA: quali sono
La dislessia fa parte di una categoria più ampia, i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), che si distinguono in base alla specifica abilità interessata:
- Dislessia: difficoltà nel decodificare le parole
- Disortografia: errori grammaticali e ortografici frequenti
- Disgrafia: scrittura poco leggibile, disorganizzata o fatica nel controllo del tratto motorio
- Discalculia: difficoltà a comprendere i numeri, le operazioni e a risolvere problemi
Questi disturbi possono presentarsi singolarmente, ma spesso si manifestano in comorbilità (cioè in combinazione), rendendo il supporto personalizzato ancora più cruciale. La chiave è riconoscere che ogni persona con DSA ha un modo unico di apprendere, e il compito della società è fornirle le chiavi giuste per sbloccare il proprio potenziale.